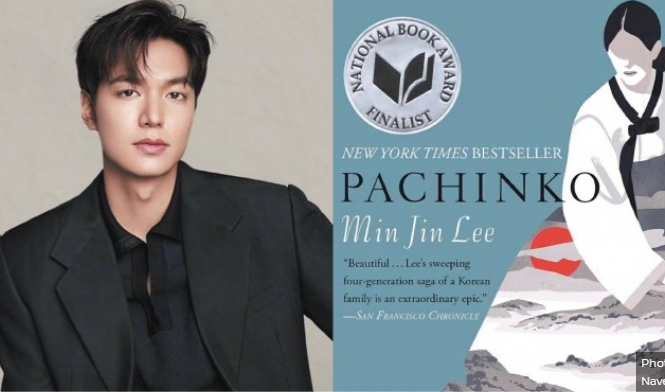Le coincidenze sono solo coincidenze? Me lo domando spesso e ancora non ho trovato una risposta rassicurante. Anche con Utz di Bruce Chatwin è andata così: ho scelto a caso l’audiolibro tra i tanti che propone il programma Ad alta voce di Rai Radio 3 e mi ritrovo il documentario Nomad, sulle tracce di Bruce Chatwin al cinema, mentre decido con quale film tornare in sala nel post Covid. Coincidenze? Chissà. Intanto, vi racconto com’è andata con l’ascolto.
Trama
Kaspar Utz, ricco praghese di famiglia tedesca, coltiva una sua esclusiva passione per le famose porcellane di Meissen, che acquista ovunque e conserva tutte nella sua casa. Costretto a subire prima l’invasione nazista e poi il regime comunista, egli intrattiene con la sua collezione un rapporto totale, che lo isola dal sinistro «rumore di fondo» della storia e lo fa perdere nelle mille storie che possono nascere dai personaggi raffigurati nelle porcellane, riconducendolo a un passato sei-settecentesco forse altrettanto terribile, ma per lui certamente felice. Ma subito dopo la morte di Utz, la collezione scompare misteriosamente e non viene più trovata.
Utz e Stevens, uniti da un filo invisibile
Bruce Chatwin andava di moda negli anni ’80, poi è scomparso dai radar. Morto giovane, Utz è il suo ultimo romanzo, scritto quando già sapeva di avere poco tempo da vivere. Ho iniziato l’ascolto incuriosita dalla trama e dalla voce di Lino Guanciale. In realtà, ad abituarmi alla voce dell’attore ho fatto fatica, eppure quando recita mi piace molto. La storia, invece, mi ha ricordato Quel che resta del giorno di Kazuo Hishiguro. Non per la trama, che ho completamente diversa, ma per l’attitudine dei protagonisti a voler conservare un mondo che non c’è più. Tanto Stevens si aggrappa alle posate d’argento, che vanno perfettamente lucidate, tanto Utz si attacca alle porcellane, che vuole preservare a tutti i costi dalla distruzione.
Uno zaino e un taccuino come moderne porcellane
Un mondo che cambia, rapporti sociali che si ribaltano, la bellezza, la bellezza degli oggetti e delle persone che non viene più riconosciuta e gettata via. Forse, in ogni momento di passaggio c’è uno Stevens, o un Utz, a conservare quello che prima o poi tornerà di moda. Come ha fatto il regista di Nomad con lo zaino di pelle di Bruce Chatwin e il suo inseparabile taccuino, che ha dato il via alla moda del Moleskine, e che rappresentano per noi delle moderne porcellane.
Che fine ha fatto la collezione di Utz?
Già, che fine avrà fatto? Che teoria avete voi? L’io narrante, lo scrittore stesso?, cerca di capire cosa ne sia stato, ma l’unica ipotesi è che Utz abbia voluto portare con sé dopo la morte le amate statuette, distruggendole e affidandone i cocci a una discarica, pur di non farle cadere nelle mani insensibili dei funzionari governativi, cosa che in vita lo preoccupava più di ogni altra cosa. Un pensiero eretico, il suo, la sparizione delle statuine.
Lui era l’ultimo al mondo a sminuire il valore di chi rischiava il campo di lavoro per pubblicare una poesia su un giornale straniero, ma a suo modo di vedere i veri eroi di quella situazione impossibile erano quelli che non aprivano mai bocca contro il partito o lo Stato e, tuttavia, parevano albergare nelle loro teste la summa della civiltà occidentale. Con il loro silenzio, disse, infliggono allo Stato un estremo insulto, fingendo che non esista…lo Stato, con tutti i suoi sforzi di cancellare ogni traccia di individualismo, offriva all’individuo intelligente un’infinità di tempo in cui coltivare, in privato, i propri sogni e pensieri eretici.
Bruce Chatwin, infatti, si è ispirato a una storia vera. Lui, che lavorava da Sotheby’s aveva saputo di un grande esperto di porcellane, un collezionista eccezionale. L’anno che precedette la primavera di Praga, andò a trovare il collezionista, Rudolph Just, e passò alcune ore con lui e la sua collezione. Just morì a metà degli anni Settanta e della sua collezione non c’è stata traccia, fino al suo ritrovamento nel 2001. Questo Bruce Chatwin non poteva saperlo e inventò una romantica e tragica fine per le sue porcellane. Anch’io, che leggendo il libro non sapevo di questa vicenda realmente accaduta, non la pensavo come il narratore. Secondo me, invece, c’entra una donna. E’ Martha l’artefice di tutto. Anche Rudolph Just avrà avuto la sua Martha? Voi la pensate come Bruce Chatwin o come me sulle porcellane di Utz? Scrivetemi nei commenti la vostra teoria.
Leggi anche: